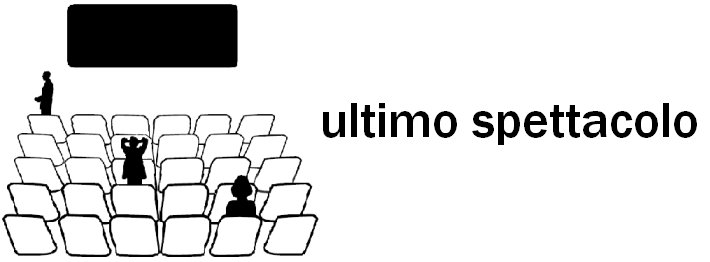Fratello e sorella
vengono esclusi dall'eredità della madre, e il padre se ne frega
delle loro rimostranze (che lavorassero, piuttosto). Si decidono
allora, con scarsissime remore, per un'azione estrema, punitiva,
coinvolgendo come complici prima un ragazzo e dopo una giovane
(Matilde Gioli), che si ritroveranno in balìa delle loro bizzose
decisioni criminali.
Tagliaferri, che
co-sceneggia, è da anni aiuto regista di Matteo Garrone, che con la
sua Archimede produce questo esordio (insieme a RaiCinema). Esordio
che per qualche aspetto ne ricorda un altro, italiano e in concorso
lo scorso anno, I figli della notte:
contestate (Blue Kids ha
schifato alcuni, ha fatto partire dei fischi, mentre altri lo
difendono sostenendo “imperfetto ma...”) opere prime di registi
che sembrano voler lasciare un segno “utilizzando” per la prima
volta la macchina da presa in un modo vistoso. Il film è infatti
estremamente concentrato sull'aspetto visivo: Tagliaferri ama giocare
tra quel che a fuoco e quel che non lo è (ad esempio nelle
inquadrature in cui è fuori fuoco quel che non è in primo piano e
lo sono i volti che si affacciano vicino alla camera), tra quel che è
in campo e quel che lascia fuori (esempi: la cerebrale scelta di
lasciare praticamente ai margini il fattaccio principale, o la
sorella che si sveglia mentre di là si sta facendo l'amore).
Insomma, non è che qui manchino idee di regia, anche nel solco di un
certo cinema contemporaneo attento all'immagine studiata o seducente
(vedi il padre al lavoro circondato dai pulcini, o l'immancabile [?]
passaggio con la protagonista che canta, su un palco). Ma questo
mettersi in mostra come regista, trascurando la scrittura alla lunga
non si rivela vincente, producendo un risultato carente e con un che
di asfittico, nonostante Tagliaferri ogni tot posi lo sguardo sugli
ambienti che circondano i luoghi della vicenda, e stemperi, cercando
il dolente, con le (belle) note in colonna sonora.
Di
per sé si può considerare apprezzabile la scelta di una storia
nera, con due protagonisti negativi, di bell'aspetto ma di fatto
freddi, chiusi assassini (a margine c'è il loro modo non
convenzionale di vivere la sessualità: lei è lesbica e il
personaggio della cameriera Gioli viene condiviso dai due), con cui
non si empatizza. Storia abbastanza essenziale (il film dura appena
75') ma resa più significativa, almeno nelle intenzioni, dallo
stile. Se il fatto che i personaggi del film non abbiano un nome può
suggerire un che di universale, al di là di suggestioni
cronachistiche, resta che i due non risultano né rappresentativi di
qualcosa come un disagio giovanile, societario, contemporaneo, e
neppure ne esce un buon ritratto di due personalità: il disegno dei
personaggi è vago, e non basta il pensare che sia cosa intenzionale,
anche perché pure un accenno di approfondimento, come il ritornare
consolatorio dalla nonna che li riporta a quand'erano bambini, resta
lì, appeso. I dialoghi non sono molti, ma qualche volta deludono,
andando nel didascalismo, così come non persuadono alcune svolte di
sceneggiatura (la sorte della cameriera), un debole finale aperto o
volendo anche una situazione che sembra di riporto come lui che si
incazza con lei una volta giunti nel “rifugio”nel riporto (quando
lui si arrabbia con lei..).
Lo
sguardo tra l'ambizioso, il distante e l'amorale del regista va alla
ricerca di un mood, ma
è come se Blue Kids fosse
un esperimento di cinema fatto di più componenti, non tutte
malvagie, che però insieme non quagliano in un film riuscito. Tra i
due protagonisti, è Agnese Claisse, rispetto a Fabrizio Falco, a
bucare di più lo schermo.
A.V.