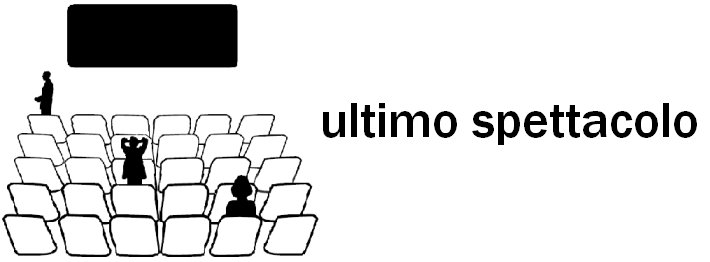Usa 2018. Di Ivan Reitman. Al cinema dal 21 febbraio 2019 ("The Front Runner-Il vizio del potere".
Lunga tre mesi (e un
prologo), la vera storia della debacle politica di Gary Hart,
senatore democratico candidato alla presidenza Usa nel 1988, dopo un
tentativo fallito nel 1984. Volenteroso, benintenzionato, Hart ha
chances ma commette l'errore di intraprendere una relazione
adulterina con una ragazza, Donna Rice - il passaggio incriminato del
loro incontro, e il loro rapporto, sono lasciati fuori dalla
narrazione: nel primo caso, Hart la nota, la segue... poi vediamo
solo lo yacht su cui si trovano in compagnia, da lontano. Eppure è
il momento chiave: niente male - . Una volta scoperta, la pressione
mediatica lo condurrà verso la rinuncia alla carica.
Aperto da un lungo piano
sequenza, con la camera che va avanti e indietro tra folla e
giornalisti fuori dall'albergo di Hart nel momento della sua prima
sconfitta, The Front Runner (con
l'ameno doppio senso esplicativo del nostro sottotitolo) ha per
personaggio principale un uomo ingenuo e idealista nella
visione della politica, e anche della gente, da lui rispettata al
punto di pensare che la cosa pubblica non venga più seguita a causa
dell'interesse pettegolo per il privato. Dovrà rendersi conto con
fastidio e fatica che non vive in una bolla, perché nel bene e nel
male la politica è fatto collettivo.
Il fatto che Hart-Jackman dopo
essersi fatto pescare resti per un bel po' in disparte dà peso agli
altri personaggi e attori - di un buon cast - : da J. K. Simmons
come Bill Dixon, capo dell'entourage, al giornalista nero
(Bill Martin) col quale Hart litiga, non riuscendo a contenere la sua
mancata sopportazione della curiosità gossip, e di cui poi diventa
quasi amico. Ecco, in un film americano di oggi, le pressioni
culturali contemporanee spingono a guardare con attenzione al lato
politicamente corretto e femminista: se pesa, cosa viene detto, se
sembra un pegno ai tempi. Qui il personaggio black ha un
rilievo in tal senso sospetto, tuttavia è abbastanza solido. Donna
pronuncia una buona battuta, rivolta a Dixon a scandalo scoppiato,
spiegandogli cosa sta facendo nella vita: più o meno, “Ho fatto di
tutto per evitare di essere guardata come mi sta guardando adesso”.
Il (breve) rapporto di questa donna dello scandalo con una ragazza
dello staff del senatore, Irene, vede la prima aprirsi, e Irene è
quella che con lei empatizza di più (pur “rosicando” sentendosi
meno attraente), infatti poi proverà a chiedere di lasciarla fuori
ai colleghi: proposta malamente respinta. C'è un momento di
messaggio morale esplicito per bocca di una donna, quando in
redazione Martin, chiedendo a una collega come mai sia così acida
quando si parla di Hart, gli risponde ferma: pazienza fosse un broker
qualunque, ma dal presidente ci si aspetta un comportamento serio. Ma
niente di grave: non si sta parlando dei didascalismi del pur
superiore The Post.
Hart però resta un
personaggio non antipatico, che si chiede cosa è diventata e
diventerà la politica, con la ricerca mediatica dei personalismi.
Questioni, domande poste chiaramente, compresa un'immagine finale in
cui convivono, in tono dimesso, dimensione pubblica e privata. Se all'inizio il rimpallo
di battute tra membri dello staff potrebbe far pensare a un film
diverso da quello in arrivo, The Front Runner è
comunque cinema americano godibile e vispo, che nell'intrattenere
inietta una componente “impegnata” la quale, sebbene non espressa
con perifrasi, merita una riflessione per la sua valenza (anche)
attuale.
Alessio Vacchi
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=BAOYDcnVx6E