
Tit.or.: Ganjeung. Corea del Sud, 2010.
Presentato in concorso ed accolto in maniera piuttosto tiepida, questo A Confession è una pellicola particolare, che colpisce e lascia uno strascico tangibile dopo la visione. Opera prima del giovane Park Su-min, classe 1981, il film si distingue per il rigore stilistico, la freddezza e la lucidità del racconto, la solennità dell’ intero impianto narrativo. Si parla, ancora una volta, (anche) di vendetta, tema assai caro alla cinematografia coreana, ma in modo diverso rispetto a film a noi noti, come la splendida trilogia di Park Chan-wook o il bellissimo I Saw The Devil di Jee-woon Kim. Qui abbiamo un ritmo molto lento, quasi pacato, per un concetto di nemesi che serpeggia sotto la pelle fragile di un cattolico perdono.
Il film narra la storia di Park Duk-joon, anziano ex-poliziotto, e “specialista in interrogatori” (ossia, torturatore), che vive come per forza di inerzia, con lo sguardo perennemente basso; oppresso dalla solitudine, dall’insonnia e dal suo passato, l’uomo sopravvive ri-esercitando, occasionalmente, la sua attività per conto di un gruppo di malviventi. Si aggrappa disperatamente alla fede, in un conflitto interiore che lo annulla.
Qualcosa sembra cambiare, quando incontra la signora Lee, amica che potrebbe diventare un amore, anche lei profondamente cattolica. Lo invita ad un incontro in chiesa, durante il quale, in modo inaspettato, ritrova il suo superiore di tanti anni prima, quando entrambi estorcevano confessioni per mezzo della tortura, e sotto l’egida dell’ essere poliziotti. Determinante sarà anche l’ incontro col giovane nipote della donna, che farà riaffiorare in lui ciò che non si è mai realmente sopito.
Ritratto di una disperazione, ma non solo: il personaggio di Park Duk-joon è sfaccettato, in bilico tra una fede ipocrita solo in parte e la propria, vera natura che tenta di soffocare. Il giovane regista conosce la storia del proprio Paese, e ne fa background dell’ intera pellicola; la polizia usava legalmente la tortura come metodo di interrogatorio ai tempi del conflitto con la Corea del Nord, dunque il concetto di poliziotto e torturatore si fonde, a simboleggiare il conflitto interiore del protagonista: chi in teoria dovrebbe rappresentare la giustizia ne praticava l’ esatto contrario. L’anziano ex-aguzzino è il frutto inaridito di quella prassi, l’ uso della violenza un tempo impostogli per mestiere, si è insediato come un seme avvelenato nella sua coscienza, con la quale fa quotidianamente i conti. Cerca salvezza nella fede cattolica (ampiamente diffusa nella Corea del Sud) in modo quasi compulsivo, fede che si rivela effimera, inutile; per buona parte del film la religione ci appare come monolitico pilastro, per poi crollare, completamente, nel finale, che rimette tutto in discussione, e fa cambiare l’ottica con la quale ci si è approcciati alla narrazione. La vendetta arriva in modo silenzioso, in sordina, ma è come se fosse stata pazientemente in agguato per tutto il tempo. Il protagonista è ingiudicabile, non ascrivibile alle manichee distinzioni tra “buoni e cattivi”, in perenne bilico tra un Male che lo divora e un Bene posticcio sul quale cerca, disperatamente, di arrampicarsi.
Il titolo internazionale è, in realtà, fuorviante: il regista stesso ha spiegato che la parola “ganjeung” ha il significato di “redenzione”, piuttosto che di “confessione”. In quest’ottica, il ribaltamento di messaggio del film è ancora più evidente, ed il reale significato del titolo suona tristemente ironico. La regia è sobria, rigorosissima nella forma, forse non ancor matura ma in ogni caso promettente. La fotografia è algida, a simboleggiare una costante assenza di emozioni, un vuoto interiore dal quale non c’è scampo.
Il protagonista tortura tramite l’acqua: bellissime le le sequenze alle terme, qui inusuali luoghi di violenza; acqua che non purifica, che non cura, che si fa limpida arma di una violenza prima meccanica, eseguita su commissione, poi viscerale, residente nell’ anima.
Un film forse non perfetto, penalizzato anche dal ritmo eccessivamente lento ma che resta accanto allo spettatore anche dopo i titoli di coda, strisciante, come la vendetta che lo pervade.
C.P.
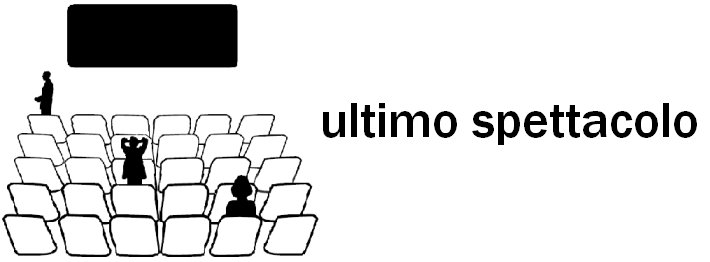
Nessun commento:
Posta un commento